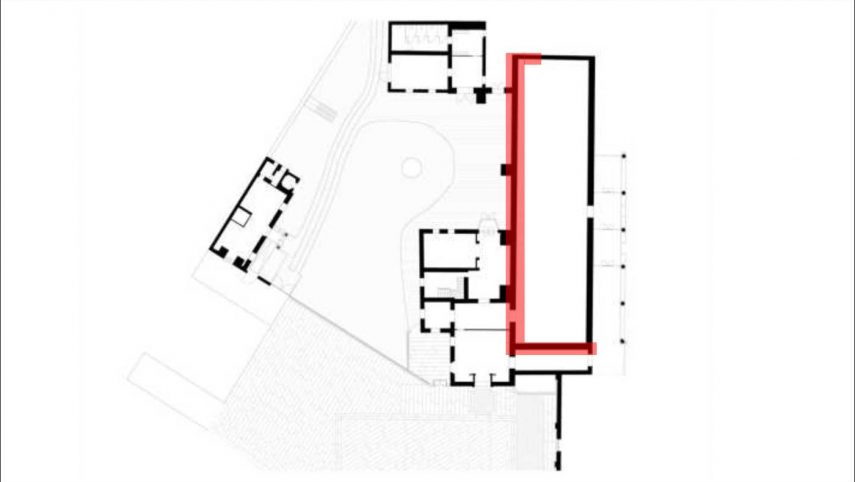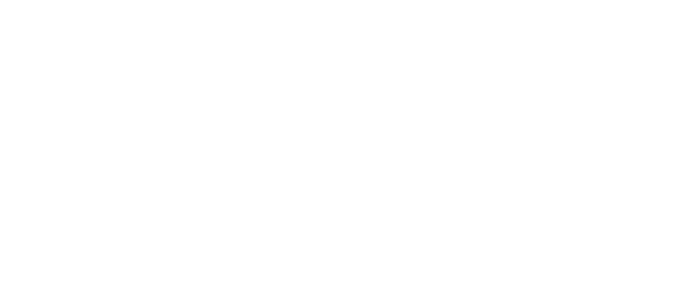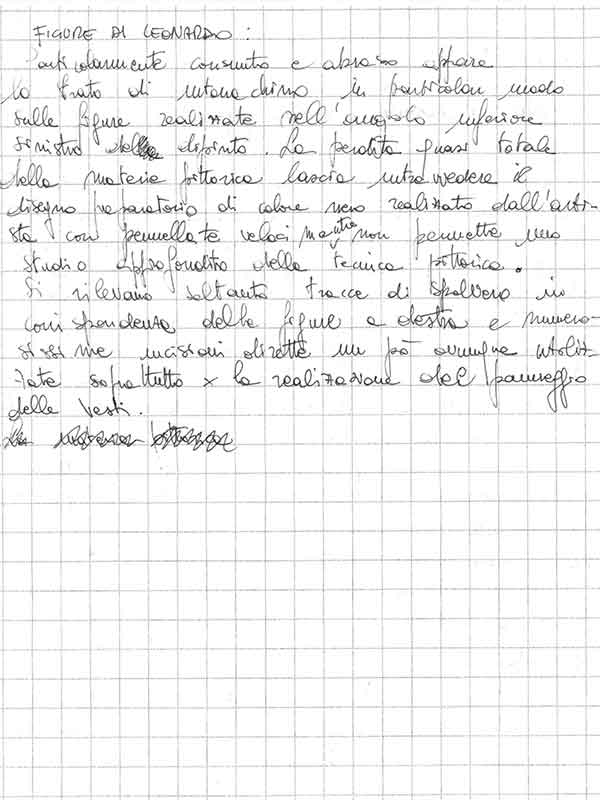6. Affresco e tecniche a secco, lamine metalliche
L’osservazione ravvicinata della Crocefissione ha permesso di individuare non solo le “giornate” di lavoro (ne sono state identificate più di quaranta) ma anche le diverse tecniche utilizzate nell’esecuzione dell’opera, che comprende parti eseguite “a fresco” e altre “a secco”.
Con il termine tecniche “a secco” si intendono le stesure eseguite sull’intonaco asciutto, con pigmenti mescolati con leganti diversi, organici (caseina, uovo, olio) o minerali (calce). La combinazione di tecniche differenti non va interpretata come un errore dell’artista sorpreso dall’asciugatura imprevista dell’intonaco: in questo caso avrebbe infatti sostituito la porzione di superficie asciutta con l’intonaco “fresco”. Al contrario, il passaggio da una tecnica all’altra era stato previsto ab initio, per ottenere effetti particolari o rispondere alle esigenze di pigmenti che si alterano con la calce. Lo spiega molto bene il Libro dell’Arte, il celebre trattato che il pittore Cennino Cennini scrisse a inizio 400, illustrando le principali tecniche pittoriche adottate dagli artisti della sua epoca, e che per noi è fonte fondamentale.
La tecnica esecutiva di Montorfano è coerente con le indicazioni generali in esso contenute ma soprattutto con la tradizionale predilezione lombarda per una pittura ricca, operata e dalla superficie varia.
Nel dipinto di Montorfano ad esempio quasi tutti gli elmi e le armature dei cavalieri, ma anche altri particolari, come le punte delle lance e il secchio dell’uomo ai piedi della croce, non solo sono a rilievo, ma presentano tracce di una lamina metallica, quasi certamente di stagno ora ossidato e scuro, applicata “a missione” cioè con una miscela adesiva oleo resinosa (mordente) che poteva avere colorazioni diverse, dal bianco al rosso.
Le lamine venivano aggiunte sulla pittura finita, quando la malta era perfettamente asciutta, e fatte aderire grazie al mordente. Le foglie metalliche oltre che in stagno, come in questo caso, potevano essere in argento, che però si ossida ancora più rapidamente (come scriveva Cennino “non dura e vien negro”), oppure in oro. Naturalmente questo era riservato ai nimbi e rivestiva borchie e decorazioni in rilievo dei finimenti dei cavalli.
Nella Crocefissione l’oro impreziosiva poi l’orlo delle vesti, le modanature e i capitelli che definiscono le lunette, le stoffe degli stendardi. Sono, purtroppo, completamente perdute le dorature che ornavano i bordi della veste di Cristo, quelle dei soldati ai piedi della croce che giocano a dadi, e quelli del manto di Giovanni e della pia donna che sorregge la Vergine Maria. Le possiamo leggere ormai solo in negativo, attraverso le tracce lasciate dalla “missione” e dalle lacune del colore di fondo.
Ma grazie allo studio ravvicinato dell’opera sono state scoperti e riscoperti tanti altri dettagli sull’esecuzione della Crocefissione.
Vuoi sapere quali? Segui i prossimi aggiornamenti.